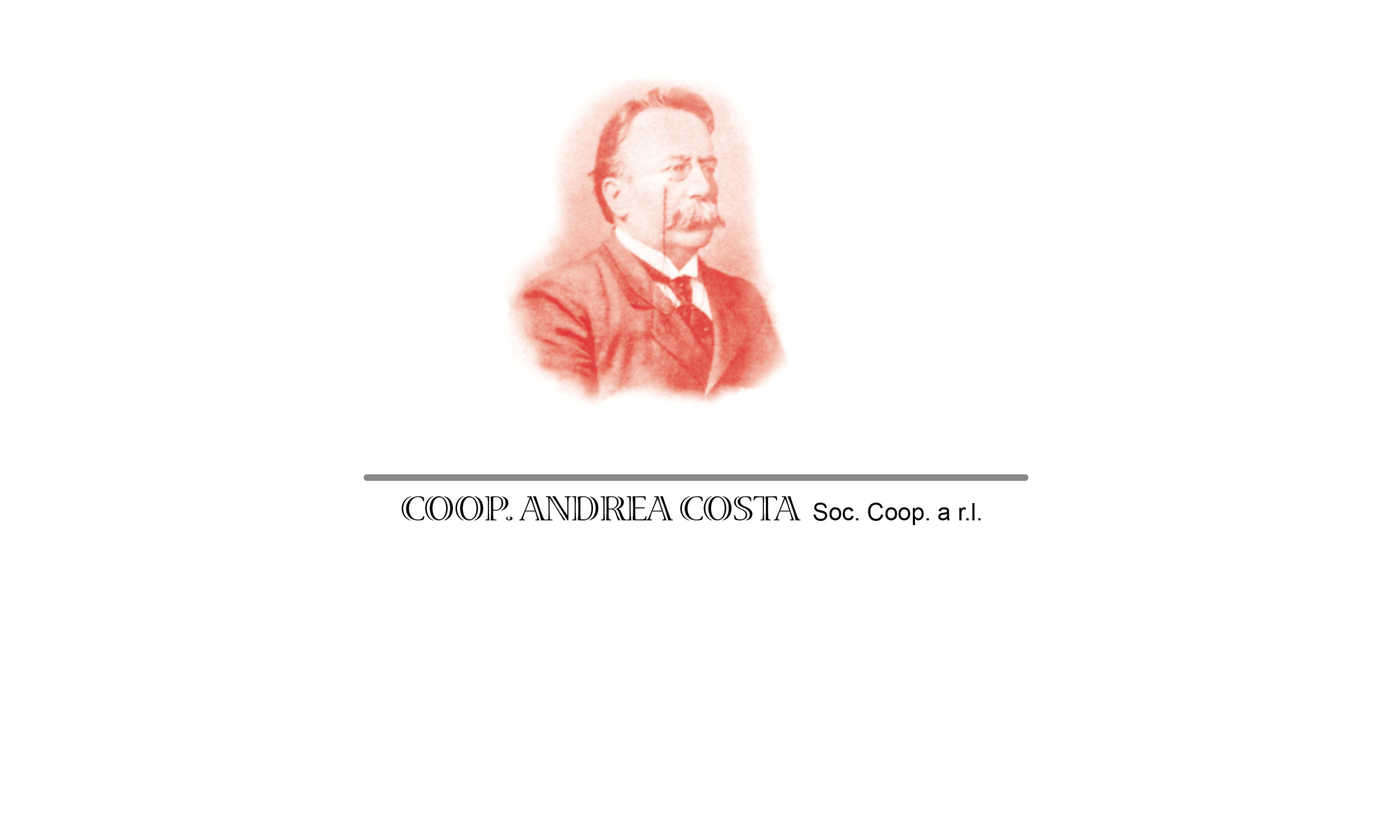La Biografia di Andrea Costa
COSTA, Andrea. – Nacque ad Imola il 30 nov. 1851 da Pietro Casadio e da Rosa Tozzi.
Il padre, che sposò poi in seconde nozze Teresa Selvatici, era domestico in casa Orsini; Orso Orsini fu padrino di battesimo del suo primo figlio, e per lui suggerì il nome di Andrea; il cognome Costa era quello del presunto nonno paterno. Pietro Casadio nel 1861 lasciava gli Orsini e apriva una bottega di granaglie. Imbevuto dei clima sanfedista allora imperante ad Imola, città che vantava i natali di G. M. Mastai Ferretti, avrebbe voluto avviare il figlio al seminario. Il giovane C. frequentò invece il liceo di Bologna.
Nel 1866 tentava inutilmente di arruolarsi tra i garibaldini, una prima volta dichiarando di avere 17 anni, e una seconda volta insinuandosi sul treno che portava a Brescia i volontari imolesi, ma fu scoperto e rimpatriato dalla polizia. Finito il liceo, dovette impiegarsi come scritturale nell’agenzia imolese delle Assicurazioni generali di Venezia. Contemporaneamente, si iscrisse come uditore alla facoltà di filosofia e lettere di Bologna; spesso, per frequentare i corsi, doveva percorrere a piedi i trentacinque chilometri di distanza da Imola. Fu assiduo alle lezioni di G. Carducci, che lo prese a benvolere (lo chiamava “il romagnolino”) e con lui avrebbe intrattenuto un lungo rapporto fatto di affettuosa e reciproca stima. L’insegnamento del Carducci lasciò un segno indelebile nella sua formazione, ne definì e coordinate umanistiche e lo sfondo ribellistico-retorico. Le ristrettezze finanziarie indussero il C. a inoltrare al sindaco di Imola due richieste di sussidio. La prima non ebbe risposta; la seconda, corredata da una presentazione del Carducci, fu respinta con una motivazione che rinviava alla “sua fama di ribelle ad ogni tradizione”. Il diniego segnò la sua sorte: alla fine del 1871 il C. abbandonava gli studi.
Il 27 novembre dello stesso anno era sorto a Bologna il Fascio operaio locale. Oltre ad essere la prima filiazione dell’Internazionale in Emilia, era anche la prima organizzazione regionale libera dalla tutela del Mazzini. Sull’onda dell’entusiasmo per la Comune di Parigi e tramite E. Bignami il C. si iscrisse all’Associazione internazionale dei lavoratori, e il Consiglio generale di Londra gli attribuì la matricola 1243. Rivelò subito un’attitudine di leader e il suo orientamento influenzò quello di tutto il gruppo; collaborava al periodico dell’associazione bolognese (Fascio operaio. Periodico democratico sociale organo dell’ associazione di tal nome della sezione di Bologna) diretto da E. Pescatori, e cominciò a prodigare tutte le sue energie nell’attività politica.
“Tutto ricadde su di me”, scrisse nel diario redatto in carcere nel 1898 rievocando quel periodo (cit. in Schiavi) “ed io mi presi addosso tutto. Non v’era compito che mi spaventasse, che mi imbarazzasse. Giornale, corrispondenza, propaganda, discorsi, amministrazione”. Il suo attivismo divenne in breve proverbiale, e i risultati non mancarono. Dell’impegno del C. in questo periodo resta la testimonianza resa dal procuratore del re nella requisitoria al processo di Bologna del 1876. Questi gli attribuì, non senza una punta d’ammirazione, “il rapido formarsi dell’Internazionale italiana”, e a sostegno di ciò esibì la documentazione contenuta nel carteggio della Commissione di corrispondenza della Federazione italiana, relativo al 1872-71 sequestrato dalla polizia all’imputato F. Natta. Il carteggio era, secondo il procuratore, “un monumento prezioso, che rivela quale fosse la di lui [del C.] prodigiosa attività, qual predominante influenza esercitasse e come in breve tempo riuscisse a dare alla Federazione un organamento e un assetto vigoroso e promettente”. Il C. fu insomma il protagonista del primo anarchismo italiano, e la sua biografia fu per qualche tempo inscindibile dalla storia di quest’ultimo.
La ripulsa del Mazzini per la Comune di Parigi aveva diviso e messo in crisi gli ambienti internazionalisti italiani e aperto una fase di competizione e di confronto. In questo clima si svolse il primo congresso del Fascio operaio di Bologna (17-19 marzo 1872), dove intervennero quattordici sezioni emiliane. Il gruppo romagnolo fece blocco con i napoletani e questo connubio garantì il successo alla tendenza più radicale; la vecchia direzione E. Pescatori-C. Ceretti, di matrice garibaldina, venne sostituita di fatto dal binomio L. Nabruzzi-A. Costa, reso più forte da un accordo intervenuto tra quest’ultimo e C. Cafiero.
Era dunque in atto un tentativo di emancipazione dai padri fondatori della democrazia italiana, e il C., che era stato tra i primi a resistere al carisma del Mazzini, non era più tenero con l’altro: o Garibaldi – aveva scritto – è per noi più pericoloso di Mazzini. Alla fine le teorie mazziniane sono un tutto organico che possiamo combattere per mezzo della scienza e che il popolo non comprenderà mai; ma la dittatura militare garibaldina è una terribile realtà, alla quale non manca che l’occasione favorevole per manifestarsi e che troverebbe facilmente la sua sanzione nella coscienza popolare” (cit. in Schiavi).
Le cause del distacco dal Mazzini non erano soltanto di ordine ideologico; richiamando infatti l’attenzione sulle campagne, il congresso di Bologna pose anche le premesse sociologiche di una strategia alternativa. Se non è dato sapere quanto ciò fu dovuto all’iniziativa dei C., è certo però che egli vi si impegnò col consueto fervore e divenne in breve un “propagandista della domenica”, approfittava cioè della giornata festiva per diffondere tra i contadini i germi della rivolta sociale. Questa esperienza, derivata dalle suggestioni populiste importate da M. Bakunin, arricchì il C. di una capacità di penetrazione del mondo contadino che resterà una dimensione peculiare del suo approccio alla politica e che verrà poi smarrita dal socialismo italiano.
Quando si costituì la Federazione italiana dell’Internazionale (Rimini, 4-6 ag. 1872), il C. fu nominato segretario della Commissione di corrispondenza con sede a Bologna. A Rimini, la dissociazione dal repubblicanesimo mazziniano e dal democratismo garibaldino progredì ed ebbe nel C. il suo più convinto assertore. Questo radicalismo, l’atteggiamento distaccato e la propensione per i toni sferzanti rinviavano anche alla età giovanile del C.; a differenza di gran parte degli altri militanti, la sua adesione all’Internazionale non era un punto d’approdo: egli apparteneva alla nuova generazione che non aveva vissuto gli entusiasmi, le illusioni e le aspettative del periodo risorgimentale. Ma rinnegare un passato come questo non era impresa dappoco, e neppure un’esigenza così imprescindibile. Fatto sta che G. Garibaldi fece pervenire a Rimini la sua adesione, e la sua versatilità politica lo rese padrino anche della nuova organizzazione. La conferenza di Rimini fu l’esito di un travagliato processo di aggregazione, ma fu anche la sede del primo emergere di contrasti destinati ad approfondirsi col tempo. Il C. trovò un valido alleato in C. Cafiero, più versato nella problematica teorica. I due si schierarono contro O. Gnocchi Viani, che poneva l’accento sugli interessi materiali della classe operaia, e gli contrapposero l’organizzazione politica e il lavoro cospirativo. Entrambi erano dunque conquistati allo universo simbolico di M. Bakunin e si preparavano a capeggiare la secessione dal Consiglio generale di Londra.
La controversia italiana venne temporaneamente sdrammatizzata al congresso antiautoritario di Saint-Imier (15 sett. 1872) grazie a una duplice formula organizzativa, che prevedeva una struttura pubblica e ampia fondata su un solidarismo e una conflittualità operaia innestati su aspettative escatologiche, e una ristretta e segreta, invece, dedita alla cospirazione antistatale.
Il C. aveva preliminarmente inviato alle federazioni spagnola e belga un messaggio di esortazione all’autonomia dal Consiglio generale di Londra, e la delegazione italiana, comprendente anche C. Cafiero, L. Nabruzzi, E. Malatesta e G. Fanelli, fu una delle protagoniste dei congresso. Lo statuto approvato in quella sede adottò per l’organizzazione cospirativa il modello massonico: gli affiliati erano inquadrati in una struttura gerarchica al vertice della quale si trovavano i “fratelli internazionali”, seguivano i “fratelli nazionali” e infine, alla base della piramide, i “fratelli provinciali”. Gli unici “internazionali” italiani erano C. Cafiero, il C., L. Nabruzzi, G. Fanelli e E. Malatesta, ma “solo il primo e l’ultimo pare possedessero tutto il cuore del loro maestro” (Romano).
Dopo Saint-Imier, l’iniziativa internazionalista si intensificò. Il C. si trattenne qualche settimana in Svizzera presso M. Bakunin per compilare un Programma oggetto della Federazione italiana. Sotto la guida di quest’ultimo, preparò anche un giornale, La Rivoluzione sociale, da introdurre e diffondere clandestinamente in Italia. Bakunin stava allora meditando su un piano insurrezionale di raggio europeo con epicentro in Italia e in Spagna. La rivoluzione spagnola del 1873 sembrò confermarne la fondatezza, e gli ambienti internazionalisti italiani ne furono galvanizzati. L’appuntamento decisivo fu il congresso federale di Bologna (15-17 marzo 1873). che si svolse in un clima movimentato. Era stato in origine convocato a Mirandola, ma qui, il 15 marzo, vennero effettuati alcuni arresti; il C. venne avvertito per tempo dal Nabruzzi e riuscì a dileguarsi. A Bologna si tenne tra l’altro una seduta speciale e riservatissima su C. Terzaghi, leader del gruppo torinese, di cui era stata accertata l’attività delatoria. In base a una relazione preparata dal C., ne fu decretata l’espulsione.
Alla conclusione dei lavori il C. venne arrestato con altri compagni e rimase in carcere per due mesi. Ma le autorità non riuscirono a trovare prove sufficienti a condannarli: i documenti sequestrati al momento dell’arresto erano già comparsi sui giornali e non potevano fungere da corpi di reato.
Uscito di prigione, si gettò di nuovo a capofitto nel lavoro organizzativo. Fondò nuove sezioni nelle Marche, in Romagna, in Emilia e in Toscana; organizzò a Bologna due gruppi di studenti e due di donne, e fu in quell’occasione che conobbe Violetta Dall’Alpi, una sartina quindicenne, figlia di un tipografo internazionalista, segretaria della sezione bolognese. Il C. se ne innamorò e da quel legame sarebbe nato il suo primo figlio, Andreino.
Partecipò quindi al congresso dell’Internazionale antiautoritaria tenuto a Ginevra (16 sett. 1873), delegato dalla federazione umbro-marchigiana, dalle sezioni di Venezia, Poggibonsi, Siena, Imola, Faenza, Pisa, Menfi e dai circoli di propaganda socialista di Taranto e di Palermo. Tracciò una breve storia della Federazione italiana e delle cause del suo rapidissimo sviluppo; disapprovò l’esclusivismo operaio recepito dallo statuto generale in funzione dei rapporti col gruppo marxista, e contrappose lo sciopero generale, integrato nel programma insurrezionale, allo sciopero parziale, che definì “polvere negli occhi”.
Le tensioni sociali avevano intanto raggiunto in Italia il livello di guardia; nel novembre, il C. fotografava in termini solo apparentemente generici lo stato di estremo disagio e di profonda inquietudine delle classi subalterne: “La miseria che aumenta con l’avvicinarsi dell’inverno, gli errori e gli atti arbitrari del governo, la colpevole indifferenza di chi è felice, fanno ingrossare il malcontento e le passioni rivoluzionarie delle plebi affamate. Interrogate gli operai delle campagne, interrogate quelli delle città: tutti vi diranno che non può più andare così, che bisogna farla finita con i signori e che il popolo sa che cosa deve fare per risolvere la situazione” (lettera del 28 nov. 1873, pubbl. da: Boll. della Fed. italiana, 7 dic. 1873).
In dicembre incontrò con altri in Svizzera Bakunin e Cafiero e fu messo a punto il progetto insurrezionale. Si decise di sollecitare la mobilitazione di altri gruppi e di provvedere ad iniziative di propaganda; la Federazione si mutò in Comitato italiano per la rivoluzione sociale. Il C., sempre instancabile, compì alla fine dell’anno innumerevoli viaggi per la penisola, dove, in seno alle federazioni più numerose, promosse la costituzione di comitati dell’Alleanza, e parecchi in Svizzera, per tenere i contatti con Bakunin. La polizia, forse preavvertita da C. Terzaghi, era al corrente dei suoi movimenti.
Sotto la supervisione di Bakunin, redasse i tre Bollettini del Comitato e due Manifesti, dei quali ultimi il primo, del gennaio 1874, venne spedito a Firenze, nuova sede della Commissione di corrispondenza, stampato e affisso a Roma; il secondo, che parafrasava un manoscritto di Bakunin, era indirizzato “al popolo italiano” e venne reso noto nel marzo. Il primo Bollettino uscì a capodanno, il secondo il 2 maggio, e in questo si leggeva tra l’altro: “Non date ascolto a Garibaldi; il socialismo quale egli lo intende è un equivoco; quelle che egli chiama le esagerazioni dei socialisti sono i principi fondamentali; egli vorrebbe che le associazioni operaie dovessero essere press’a poco tante Società di mutuo soccorso: togliete alle medesime il programma e il carattere rivoluzionario e saranno la più meschina cosa del mondo, di cui rideranno i borghesi. Su via, rovesciamo questo mondo che ci schiaccia, distruggiamo questa società che ci rinnega, vendichiamo tutte le onte, gli insulti, le ignominie, le abbiezioni che soffrimmo e che soffriamo”. Il terzo appello, del luglio, fu il segnale dell’insurrezione, rivolto al popolo e all’esercito “Perché s’uniscano ai ribelli per abbattere il privilegio, insorgendo tutti contro i poteri costituiti”.
Mentre fervevano questi preparativi, il C. fu coinvolto in un episodio che dà la misura del prestigio da lui raggiunto in questo periodo nelle campagne romagnole, di un legame con le masse contadine che né il passare del tempo né il mutare della situazione riusciranno ad incrinare, e che non sarà peraltro scevro da una sua angustia regionale. Il disagio annonario aveva già provocato tumulti in quasi tutto il paese. Il 2 luglio 1874 un gruppo di donne esasperate si raccolse alla stazione di Imola per impedire la partenza di tre vagoni di grano; un centinaio di uomini si tenevano in disparte, silenziosi, pronti a farsi avanti in loro aiuto alla prima occasione. Un drappello di carabinieri teneva a bada i dimostranti. L’atmosfera si stava surriscaldando quando il C. scese dal treno proveniente da Bologna. Le donne gli si fecero incontro chiamandolo per nome e sollecitandolo a intervenire. Il C. parlamentò con gli uni e con gli altri, e riuscì a scongiurare la partenza del grano.
La data dell’insurrezione venne fissata al congresso straordinario di Bruxelles (12 ag. 1874). Il C. lesse un rapporto della Commissione di corrispondenza della Federazione italiana e dichiarò di poter contare su 30.000 uomini., 4.000 fucili Wetterly e 1.000 bombe. Le armi erano state acquistate con gli ultimi residui del patrimonio di C. Cafiero e raccolte dal C. e da E. Malatesta alla Baronata, la residenza svizzera di Bakunin. Nel tentativo di coinvolgere i repubblicani, venne convocato a Genova un convegno segreto che non approdò a nulla, e C. Ceretti accusò in seguito il C. di aver fatto precipitare le cose per contrastare un’alleanza a lui sgradita. L’inizio dell’insurrezione fu comunicato alle sezioni dell’Internazionale con la frase convenzionale: “Le note operazioni commerciali saranno notificate in agosto”. Il C., che aveva assunto per l’occasione lo pseudonimo di Antonio De Andreis, era di fatto il primo aiutante di campo di Bakunin, che dell’insurrezione era il capo. L’epicentro prescelto era Bologna e lìvenne fissato il quartier generale; ma l’inopinato arresto del C., il 5 agosto, provocò un subitaneo disorientamento tra i congiurati e, malgrado sporadiche sollevazioni, decretò il fallimento dell’impresa e l’arresto di una folta schiera di internazionalisti. Il 9 agosto il governo sciolse tutte le sezioni dell’Internazionale, la cui direzione fu assunta dal Cafiero.
Dalla delusione si passò alle recriminazioni: il C. fu accusato di ottimismo e di superficialità, errori che più tardi, nel diario del 1898, ebbe anch’egli ad ammettere. Rimase in carcere fino al 18 giugno 1876. Passava il tempo immerso nello studio delle lingue straniere, l’inglese, il russo e lo spagnolo; non dimentico della sua formazione umanistica, leggeva Plutarco, Platone, Dante. I processi agli internazionalisti mobilitarono l’opinione pubblica assai più di ogni loro precedente iniziativa autonoma. La generosità e la dignità del contegno degli imputati, nonché l’impopolarità dello Stato che essi avrebbero voluto abbattere, suscitarono in tutto il paese una viva ondata di simpatia. Il filosofo E. Ferrari sconcertò gli ambienti democratici pronunciando alla Camera un discorso in loro difesa.
Il C. fu il protagonista assoluto del processo di Bologna, che convogliò l’attenzione maggiore. Lo difendeva un principe del foro, l’avvocato repubblicano G. Ceneri, e a deporre in suo favore si presentarono l’antico maestro G. Carducci e il leader repubblicano A. Saffi. La partecipazione popolare divenne imponente il giorno dell’interrogatorio del C.: “Quando si seppe in città che esso doveva avere inizio”, si legge nel resoconto comparso sulBulletin della Fédération jurassienne del 24marzo 1876, “la folla accorse in proporzioni maggiori del solito. Si è notato che gli allievi delle scuole hanno abbandonato le lezioni per venire all’udienza e ascoltare Costa”.
Gli imputati negarono quasi tutti l’esistenza del complotto. Il C. rifece la storia dell’Internazionale e pronunciò una vera e propria autodifesa: Del nome di malfattori”, disse tra l’altro, io e i miei compagni non ci occupiamo. Teniamo pertanto conto di questo: che i borghesi, quegli stessi borghesi che un secolo fa erano chiamati dalla nobiltà straccioni e senza brache, oggi, saliti al potere, per mezzo di loro rappresentanti ci chiamano malfattori e peggio che malfattori. Ebbene, questo titolo lo accettiamo come fece un giorno la borghesia e chi sa che un giorno, come la croce da strumento di infamia divenne simbolo di redenzione, questo nome di malfattori dato a noi e da noi accettato, non indichi i precursori di una rigenerazione novella”.
Il processo si concluse con un’assoluzione generale, sia perché il carattere preventivo della repressione aveva impedito la raccolta delle prove, sia perché esso ebbe luogo nel vivo di una svolta politica che aveva suscitato grandi aspettative e ingenerato un clima di pacificazione sociale: la caduta della Destra e l’avvento al potere della Sinistra.
Uscito dal carcere, il C. si adoperò ad attenuare il rigorismo cospirativo impresso dal Cafiero all’Internazionale; dissipò l’idea di un nuovo progetto insurrezionale e gestì il ritorno dell’organizzazione alla legalità. Il settarismo del Cafiero e i mutamenti politico-sociali in atto riacutizzavano lacerazioni non nuove nel campo del socialismo anarchico, ma ora non più circoscritte a singoli individui: il 10 luglio 1876 si era costituita la Federazione lombarda dell’Associazione internazionale, dal 1718 febbr. 1877, col secondo congresso dei socialisti legalitari, Federazione Alta Italia, che dava segni di sempre maggiore insofferenza per il millenarismo bakuninista. La reazione iniziale fu cauta e temporeggiatrice, specie nei confronti del periodico La Plebe, la voce più autorevole del nuovo dissenso. Nel 1877 la socialdemocrazia tedesca iniziava la sua irresistibile ascesa elettorale. La Plebe la commentò con compiacimento; il C. si assunse invece il ruolo di custode della purezza simbolica originaria e giudicò le elezioni tedesche una sconfitta del socialismo, foriere di illusioni e preludio a itinerari funesti. Nella formazione dei partiti socialisti il C. intravvedeva un pericolo oligarchico che sarebbe poi stato analizzato con ben altri strumenti metodologici, e denunciava il primato della leadership politica su masse rese inesorabilmente passive, indifferenti all’appello socialista, facili prede della reazione. La vera partecipazione alla lotta, scrisse su La Plebe (25 febbr. 1877), è possibile solo con la rivoluzione “popolare, violenta, distruggitrice, terribile e … non può essere che la guerra civile”.
Il protagonismo politico delle masse e la necessità di conquistarle alla coscienza dei propri diritti erano motivo di conflitto anche tra il C. e la componente anarchica cospirativa impersonata in Italia dal Cafiero. Il radicamento nella realtà sociale e una certa sensibilità per il mutare degli atteggiamenti collettivi furono forse il nucleo più coeso di una personalità incostante e irrequieta come quella del C. quello che può fornire la chiave meno controversa a cui ricondurre una vicenda biografica poco incline alla coerenza. La rottura col socialismo legalitario si era consumata al congresso della Federazione emiliano-romagnola (16 luglio 1876); il C., che del congresso era stato “anima e mente” (Romano), ne fu l’artefice maggiore. Frattanto, per onorare la memoria di Bakunin, morto nel 1876, la federazione di Bologna era stata incaricata di curarne la biografia; le prime quarantotto pagine furono redatte dal C. e pubblicate nel 1877.
Il 24 ag. 1876, mentre stava per raggiungere Jesi, sede del congresso delle Marche e dell’Umbria, veniva arrestato e colpito da ammonizione come “ozioso e vagabondo”. Il gruppo marchigiano era molto legato al leader romagnolo, e le Marche erano allora uno dei maggiori punti di forza della mappa dell’internazionalismo italiano; esso vi contava un notevole seguito, specie a Fabriano, dove era penetrato tra gli artigiani urbani e tra gli operai delle antiche cartiere, e a Jesi, il centro più industrializzato della regione. Nelle due città si stampava IlMartello che, dopo un tentativo fallito di collaborazione con i mazziniani, contribuì alla ripresa organizzativa dell’Internazionale a seguito del processo di Bologna. In un secondo momento, il C. ne fece trasferire a Bologna la redazione. Il Martello divenne così organo della Federazione umbro-marchigiana e, di fatto, portavoce ufficiale dell’anarchismo. Della nuova redazione facevano parte il C., A. Casalini e A. Faggioli. Il periodico ospitò l’esordiente polemica contro i socialisti autoritari “addormentatori del popolo” e una violenta campagna contro il ministro degli Interni G. Nicotera, ritenuto tra l’altro responsabile della morte “misteriosa” di G. Fanelli nel manicomio di Nocera Inferiore.
Nell’ottobre del 1876 il C. si era intanto recato a Firenze, ospite del repubblicano G. Corsi, per preparare il congresso della Federazione italiana convocato a Pontassieve; il 19 era stato arrestato per contravvenzione all’ammonizione, e il congresso si era tenuto alla meglio fuori città sotto la pioggia. L’epicentro dell’attività internazionalista venne allora spostato nel Mezzogiorno; la Commissione di corrispondenza venne trasferita a Napoli e qui si stabilirono anche, alla fine dell’anno, E. Malatesta e C. Cafiero. Il delinearsi della dissidenza settentrionale aveva infatti messo in crisi la leadership del C. e favorito l’ala più radicale. Cafiero e Malatesta erano risoluti a passare quanto prima dalle parole ai fatti.
All’inizio del 1877 venne concepito un moto insurrezionale di ispirazione molto diversa dal precedente, modellato sulla esperienza del brigantaggio. Il C. si mostrò restio e dubbioso: senza una preparazione attraverso la stampa e senza una propaganda adeguata, l’impresa gli sembrava votata all’insuccesso. Un’obbiezione piuttosto debole, poi contraddetta dal suo stesso intervento al congresso di Verviers.
Forse il lungo periodo trascorso in carcere lo aveva reso meno disponibile all’insurrezionalismo, e forse al suo relativo disimpegno contribuì anche il vedersi messo in disparte dalla nuova leadership. Difatto, questo fu il primo episodio di dissociazione dalla strategia internazionalista; ma passeranno ben tre anni prima che il C. arrivi a maturare il suo distacco ed è lecito ipotizzare che le sue reticenze non celassero riserve di carattere generale. Certo è che su questa vicenda egli eluse anche in seguito qualsiasi chiarificazione. Dopo la sua svolta politica, nella lettera di replica “Agli amici e agli avversari” (15 sett. 1881), si scagionò dalle accuse in proposito in questo modo: “È vero che non l’approvai [il moto del Matese], è falso che nulla abbia fatto perché riuscisse. Non l’approvai perché il momento mi parve male scelto e perché i tanti sui quali si contava non esistevano purtroppo se non nella calda fantasia di alcuni” (cit. in Avanti!, 20 genn. 1910).
Nicotera aveva dichiarato una guerra senza quartiere al sovversivismo italiano, senza peritarsi di ricorrere anche all’arma della diffamazione: in piena Camera, rispondendo a un’interrogazione di F. Cavallotti sull’espulsione dall’Italia di Benoît Malon, aveva dichiarato che gli anarchici italiani erano diversi da quelli degli altri paesi, e che “in Romagna erano accoltellatori, nel Napoletano camorristi, mafiosi in Sicilia”. La risposta non tardò. Il 18 marzo 1877, primo anniversario dell’ascesa al potere della Sinistra, il C. preannunciò su Il Martello l’imminente insurrezione e scrisse una violenta requisitoria contro il Nicotera: “Mentitore sfacciato, – lo apostrofava – calunniatore per sistema, ignorante e borioso, voi siete un degno ministro del Regno d’Italia. Se un giorno abbiamo potuto discutere, oggi non discutiamo più. Onorevole barone Nicotera, voi siete un vile!”. La replica del ministro venne con la repressione del moto beneventano: inviò 12.000 soldati contro una banda di cento persone, istigò alla giustizia sommaria degli arrestati e tentò anche, al processo, di corrompere i giurati.
La sfortunata vicenda del moto è nota, e del resto non appartiene alla biografia del C.; mentre i suoi compagni si davano convegno nel Beneventano, egli se ne restò in Romagna, coll’intesa di estendervi la rivolta in caso di successo. Appena, però, la notizia si diffuse, i giornali attribuirono al C. la paternità dell’insurrezione abortita ed egli fece appena in tempo a riparare in Svizzera. La giustizia italiana, comunque, non si dimenticò di lui: il 27 luglio 1877 il pretore di Imola, che già gli aveva comminato, alla fine del 1876, un mese di carcere e sei di sorveglianza speciale, lo condannò di nuovo in contumacia a tre mesi di carcere e sei di sorveglianza speciale, pene poi condonate con l’amnistia del 19 genn. 1878.
Questo soggiorno all’estero durò circa due anni, e furono anni densi di avvenimenti, sia sul piano politico sia su quello affettivo. Dopo una sosta iniziale a Ginevra, si fermò a Berna, dove si guadagnò da vivere dipingendo insegne di negozi; passò poi a Lugano, e lì conobbe nel settembre, in casa di F. Pezzi, Anna Kuliscioff. Da quest’incontro nacque un nuovo legame sentimentale che fu anche un lungo sodalizio politico; la ricca e volitiva personalità della Kuliscioff influenzò profondamente l’intera sua vita. Nello stesso periodo, prese parte a due consessi internazionali, il congresso convocato a Verviers dall’Internazionale anarchica (6-8 sett. 1877) e quello di Gand (9 sett. 1877).
Al primo era stato delegato da trentacinque sezioni e svolse un’importante relazione sulla situazione italiana, in cui illustrava le ragioni del moto di Benevento da un’angolatura oscillante tra antropologismo e romanticismo politico: “È necessario che vi rendiate conto dapprima”, disse tra l’altro, “delle condizioni generali dove avvennero i fatti. In quasi tutte le province meridionali d’Italia, la propaganda come la si intende nei paesi d’occidente è press’a poco impossibile; i mezzi di comunicazione mancano in gran parte; centri operai non ve ne sono, grandi città neanche; e la popolazione è composta su per giù di contadini che, allogati di giorno in giorno per il lavoro della terra, non hanno giammai preso parte ad una vita sociale qualsiasi, non sanno o sanno appena leggere e scrivere e vivono nella più grande miseria. Il solo mezzo che essi ebbero fino ad ora per sottrarsi al despotismo del governo e dei signori fu ben primitivo, presero un fucile, raccozzarono alcuni compagni e si fecero briganti. I briganti non sono generalmente odiati dal popolo, perché dapprima sono gente che il popolo conosce – uomini che ebbero a che fare con la giustizia, disertori o altro – e poi non toccano il bene del povero, ma fanno ai ricchi e alle autorità una guerra implacabile. Che cosa ci vuole per rendere il brigantaggio popolare? una bandiera. Qual focolare immenso di rivoluzione quando il brigantaggio potesse farsi generale e le moltitudini sollevate – a cui le bande offrirebbero un rifugio in caso di disfatta – vi prendessero parte! Allora, protette dai luoghi, sostenute dal popolo, queste bande sarebbero invincibili. Si trattava dunque di provocare un movimento di popolo, ed a mal andare di propagare almeno le nostre idee per mezzo della dimostrazione pratica della loro attuazione… “. A Verviers, il C. si schierò con Paul Brousse all’estrema sinistra del movimento anarchico e riuscì a far approvare una mozione avversa all’azione politica, sinonimo allora di azione parlamentare, che così concludeva: “Il Congresso dichiara che non esiste alcuna differenza tra i diversi partiti quando essi perseguono un programma politico, si dichiarino o no socialisti: secondo il Congresso tutti questi partiti, senza distinzione alcuna, formano una massa reazionaria, ed esso crede che sia suo dovere combatterli tutti” (ed. in Romano).
Un mese prima, gli autori del moto beneventano, detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, avevano delegato il C., con una lettera clandestina, a rappresentarli al congresso di Gand. E Gand fu l’arena di nuovi scontri. La delegazione italiana comprendeva il C. e il maloniano T. Zanardelli, e durante la discussione si fronteggiarono due correnti: i collettivisti, cui apparteneva il C., e i cosiddetti comunisti autoritari, fautori dello Stato e del parlamentarismo. Lo Zanardelli lesse un lungo rapporto anonimo, ma redatto dal Malon, pieno di recriminazioni contro gli internazionalisti italiani e ostile agli insorti di Benevento. Esso suscitò energiche proteste e lo Zanardelli, rimasto isolato, dovette ritrattare.
L’episodio irrigidì l’atteggiamento del C.: giudicò irrealizzabile la proposta di un patto di solidarietà tra le due tendenze e, col Brousse e pochi altri, si oppose alla costituzione di un ufficio di statistica comune. Ribadì anche la sua avversione per il parlamentarismo, e respinse l’ipotesi di una federazione sindacale internazionale sostenendo che in Italia, come lo era la grande industria, anche le organizzazioni operaie erano un fenomeno marginale e quelle esistenti erano più d’intralcio che di aiuto al socialismo.
Alla luce degli sviluppi successivi, però, si può presumere che una difesa così intransigente dei principi originari del socialismo anarchico fosse interrelata e proporzionale a uno stato di crisi e di profonda incertezza.
Nel novembre abbandonò la Svizzera e si stabilì con la Kuliscioff a Parigi. La coppia era angustiata da ristrettezze finanziarie e dalla salute cagionevole di Anna; il C. fu costretto a impiegarsi in un negozio di fiori. Gli antichi compagni lo stavano abbandonando, ed egli prese a frequentare i dissenzienti; L. Nabruzzi e T. Zanardelli erano i più assidui, e con essi condivise poco dopo l’arresto. Durante il soggiorno parigino, collaborò con P. Kropotkin e Guesde alla riorganizzazione dei gruppi anarchici; tra il gennaio e il febbraio 1878, partecipò al congresso operaio di Lione e sulla via del ritorno fece un giro di propaganda a Montluçon, Commentry, Gannat. Rientrato a Parigi, il 22 marzo venne arrestato e il 4 maggio condannato a due anni di reclusione e a 500 franchi di multa per essersi affiliato ad associazioni internazionaliste. La sua compagna fu espulsa dal paese.
Il carcere lo rese disorientato e depresso; progettò di scrivere un’opera letteraria ed entrò in corrispondenza col Carducci e con l’avvocato G. Ceneri, che l’aveva difeso a Bologna, chiedendo loro di inviargli il materiale necessario. Il suo stato d’animo peggiorò quando seppe dell’arresto della Kuliscioff, a Firenze, dove era andata per un congresso internazionale.
Il 1878 fu l’anno più critico per l’Internazionale italiana. Le sue ripetute sconfitte e la sordità dello Stato alla domanda sociale provocarono un’ondata terroristica. La risposta fu la più vasta operazione repressiva fin’allora attuata ai danni dell’Internazionale, equiparata a un’associazione “di malfattori”. Il suo prestigio morale ne uscì rafforzato, ma il bilancio registrò la decapitazione quasi totale del movimento. Esso cominciò ad apparire, anche al detenuto C., in preda alla disgregazione e senza prospettive.
L’elezione di Jules Grévy alla presidenza della Repubblica francese fu solennizzata da un’amnistia, applicata anche al C. il 5 giugno 1879. Pochi giorni prima di riguadagnare la libertà, il 24 maggio, anticipò in una lettera a S. Mazzotti i motivi dell’imminente svolta e, consapevole delle reazioni che avrebbe suscitato, concludeva: “Sarò forse in disaccordo con qualcuno dei nostri, ma che fare? “. Espulso dalla Francia, raggiunse prima Ginevra e poi Lugano; qui incontrò alcuni esponenti del socialismo milanese, tra cui B. Malon e E. Bignami, con i quali verosimilmente si consultò in vista della prossima, clamorosa presa di posizione pubblica; la lettera del 27 luglio 1879, indirizzata Ai miei amici di Romagna, apparve infatti su La Plebe (3 agosto).
Malgrado si tratti di un documento assai noto, è opportuno riportarne i passi più salienti. Non senza, però, richiamare preliminarmente l’attenzione sulla scelta dei destinatari della storica lettera, gli amici “di Romagna”, una delimitazione tanto più singolare quanto più essa conteneva diagnosi e proposte intese a mettere in crisi la realtà complessiva del movimento italiano e non certo un suo segmento regionale. Forse una civetteria, un tributo di modestia, ma talmente incomprensibili e ingiustificati da confermare piuttosto quella dose di provincialismo che fu una delle costanti, e dei limiti, della personalità del Costa.
Dopo un breve esordio, a parziale riepilogo delle sue ultime traversie, scriveva: “Miei cari amici! Noi ci troviamo, ormai, alla vigilia di un rinnovamento. Noi sentiamo tutti o quasi tutti che ciò che abbiamo fatto fino ad ora non basta più a soddisfare né la nostra attività né quel bisogno di movimento senza cui un partito non esiste: noi sentiamo insomma che dobbiamo rinnovarci o che i frutti dal lavoro che abbiamo fatto fin qui saran raccolti da altri. Io son ben lungi dal negare il passato. Ciò che facemmo ebbe la sua ragion d’essere; ma se noi non ci volgessimo, se noi non offrissimo maggior spazio alla nostra attività, se non tenessimo conto delle lezioni che l’esperienza di sette od otto anni ci ha date, noi ci fossilizzeremmo: noi potremmo fare oggi a noi stessi le medesime accuse che facevamo ai mazziniani nel ’71 e nel ’72 …. Noi rilevammo energicamente ed affermammo la forza viva del secolo – la classe operaia …. Nel tempo stesso che noi affermavamo l’emancipazione dei lavoratori … noi sollevammo ed agitammo tutte le questioni che vi si riferiscono: proprietà, famiglia, stato, religione, dando ad esse una soluzione in armonia con la scienza e con la rivoluzione …. Ma i tentativi di rivoluzione falliti, avendoci privati per anni interi della libertà, o avendoci condannato all’esilio, noi ci disavvezzammo disgraziatamente dalle lotte quotidiane e dalla pratica della vita reale: noi ci racchiudemmo troppo in noi stessi e ci preoccupammo assai più della logica delle nostre idee e della composizione di un programma rivoluzionario che ci sforzammo di attuare senza indugio, anziché dello studio delle condizioni economiche e morali del popolo e de’ suoi bisogni sentiti e immediati. Noi trascurammo così fatalmente molte manifestazioni della vita, noi non ci mescolammo abbastanza al popolo: e quando, spinti da un impulso generoso, noi abbiamo tentato di innalzare la bandiera della rivolta, il popolo non ci ha capiti e ci ha lasciati soli …. Noi dobbiamo fare assai più di quel che facemmo fino ad ora; ma in sostanza dobbiamo restare quel che fumino, un partito di azione …. Ma essere un partito di azione non significa voler l’azione ad ogni costo e ad ogni momento…. La rivoluzione è inevitabile, ma l’esperienza ci ha, credo, dimostrato che non è affare né di un giorno né di un anno. Perciò, aspettando e provocando il suo avvenimento fatale, cerchiamo qual’è il programma generale intorno a cui si raccolgono tutte le forze vive e progressive della generazione nostra. Questo programma è secondo me: il Collettivismo come mezzo, l’Anarchia come fine – programma d’oggi, che fu il nostro programma di ieri …. Or mi resterebbe a dirvi quali mezzi pratici io penso che si debbano mettere in opera …. Per ora, secondo me, la cosa più importante da farsi è quella di ricostituire il Partito socialista rivoluzionario italiano, che continuerà l’opera incominciata dall’Internazionale e che, federandosi o prima o poi, coi partiti simili esistenti negli altri paesi, ristabilirà su basi solide l’Internazionale che ora dappertutto è in sfacelo. L’Internazionale, come esisté fino ad ora, rappresentò un momento storico della vita delle plebi; ma non potrebbe rappresentare tutta la loro vita: noi non abbandoneremo peraltro il nome dell’Internazionale; ma vogliamo che non sia un semplice spauracchio, sì bene che si fondi sull’organamento solido dei partiti socialisti esistenti ne’ paesi diversi. Questo, amici miei, – asseriva nella parte conclusiva -, è quanto doveva dirvi. Come vedete, non si tratta di rigettare il nostro passato, di cui, nonostante le sventure e i molti disinganni sofferti, possiamo per sempre andare fieri: né di cessar di essere quel che fummo: si tratta solamente di far più e di far meglio”.
Oltre al travaglio e alla riflessione personale, all’influsso della Kuliscioff, del socialismo lombardo e di Malon, è stata avanzata l’ipotesi che alla svolta del C. abbia contribuito anche il suo accostamento alla socialdemocrazia tedesca (Ragionieri), un’esperienza che condivise con il gruppo di La Plebe. Sul settimanale Der Sozialdemokrat comparvero infatti in questo periodo corrispondenze anonime sul socialismo italiano, attribuite al C., a E. Kerbs ed a O. Gnocchi Viani. Ma l’indizio di maggior rilievo a questo proposito sarebbe costituito dalla centralità, rivestita nella lettera, dell’obbiettivo partitico.
Le congetture sulla genesi della lettera sono state tutte più o meno ritenute di difficile verifica e anche sul significato da attribuirle le valutazioni divergono: qualcuno ha ritenuto che essa sia stata considerata a torto un’opzione “riformistico-legalitaria” e ne ha proposto una lettura in chiave di adesione al marxismo, di espressione cioè “della convinzione che base indispensabile di un’azione rivoluzionaria è il miglioramento economico e politico delle classi lavoratrici” (Romano); altri ne hanno sottolineato lo aspetto accattivante rispetto a quello conflittuale (Della Peruta, 1958).
Il tono discorsivo e affettivo della lettera disorientò in una certa misura i suoi vecchi compagni. Con l’eccezione di E. Malatesta, essi stentarono a recepirne immediatamente le implicazioni politiche, e la risposta di F. S. Merlino, pubblicata anch’essa su La Plebe il 17 ag. 1879 non lasciava presagire la rottura. Una rottura che neppure il C. voleva. La sua collaborazione a Der Sozialdemokrat cessò infatti con il congresso di Weyden (20-23 ag. 1880) che adottò severe misure disciplinari a carico dei simpatizzanti con l’anarchismo, ed espulse J. Most e W. Hasselmann. Le epurazioni di Weyden furono per il C. una grossa delusione, perché “vedeva svanite o di molto rimandate nel tempo le sue aspettative per la costituzione di una nuova Internazionale che riunisse tutte le più disparate fazioni dei socialismo europeo” (Ragionieri, 1961). Si accostò allora al possibilismo francese, capeggiato dall’antico alleato dei congressi anarchici P. Brousse. Il succedersi di questi tentativi sembra suggerire l’intenzione di convogliare l’intero anarchismo italiano verso la nuova rotta, in modo da sostituire alla precedente contrapposizione frontale l’integrazione politica delle classi subalterne.
Prima di passare ad una nuova fase operativa, trascorsero alcuni mesi. La Kuliscioff, dopo aver subito a Firenze una lunga carcerazione, resa più penosa da un grave attacco polmonare, fu assolta e liberata. Nel febbraio del 1880 il C. rientrò clandestinamente in Italia e si stabilì con lei a Milano; insieme parteciparono al convegno di Bologna (14 marzo 1880), dal quale emerse il profilo di un partito socialista libero da pregiudiziali ideologiche. Il 27 marzo successivo veniva condannato dal tribunale di Bologna per contravvenzione all’ammonizione.
Motivo ricorrente della riflessione del C. era stata, in questo periodo, un’esigenza di approfondimento teorico. I problemi solo enunciati nella lettera del 1879 vennero quindi ripresi e sviluppati sulla Rivista internazionale del socialismo, fondata dal C. il 1º maggio 1880 a Milano, assieme ai socialisti di La Plebe. Rievocando qualche anno dopo le sollecitazioni che l’avevano mosso, scrisse che il socialismo doveva avere finalmente “quell’elaborazione scientifica propria, senza della quale non può uscire dallo stato di cospirazione e assumere una forma chiara, determinata, comprensibile per tutti e capace di soddisfare coloro, che lo interpretano male e lo svisano” (cit. in Lipparini). Ma l’impresa ebbe vita difficile e breve. Il C. venne di nuovo arrestato ancor prima dell’uscita del primo numero, e dovette interrompere a metà un articolo scritto per l’occasione. La Rivista cessò le pubblicazioni il 31 dic. 1880, col n. 2 del II volume.
Il 1º nov. 1880 la Società operaia di Mutuo soccorso di Imola, che contava un migliaio di soci, delegò il C. con votazione plebiscitaria, a rappresentarla al congresso indetto a Bologna per il suffragio universale dalla locale Società democratica radicale e presieduto da A. Saffi. Il discorso pronunciato allora riecheggiava i temi cari al socialismo lombardo: “Il suffragio universale”, asserì, “non è che il primo passo nelle lotte tra le classi sociali. La questione vera è di indole economica: è la lotta tra il capitale e il lavoro. Non si otterrà nulla coi mezzi legali e giuridici, ma colla forza”. Il pubblico intervenuto al comizio non si lasciò però persuadere e approvò quasi unanime l’o. d. g. di tutt’altro tenore proposto dal Saffi. La sera stessa il C. veniva arrestato. Durante la sua detenzione nel carcere di Perugia, il congresso di Chiasso (5-6 dic. 1880) recideva definitivamente qualsiasi legame dell’anarchismo col socialismo legalitario. Dominatore del congresso fu C. Cafiero.
Scontato il carcere, il C. dovette anche sottostare a sei mesi di sorveglianza speciale a Imola. Qui venne raggiunto dalla Kuliscioff, ma i loro rapporti si stavano facendo sempre più tormentati e difficili, intristiti anche da immancabili problemi finanziari, e neppure la nascita della seconda figlia Andreina (8 dic. 1881) riuscirà a risolverne la crisi; e qui fondò lo Avanti!, periodico settimanale socialista (n. 1. 3 apr. 1881).
L’indirizzo programmatico, pervaso dalla inconfondibile retorica del C., diceva tra l’altro: “Che cosa vogliono quelle donne pallide e smunte, quei fanciulli cenciosi, quegli esseri umani, che la miseria e l’ignoranza abbrutiscono e le lunghe fatiche accasciano, che soffrono la fame in mezzo all’abbondanza, che non hanno di che coprirsi, mentre i magazzini rigurgitano di panni, che sentono, pensano e ragionano, come pensavano, sentivano e ragionavano le generazioni passate, e talvolta le generazioni primitive, mentre tanta luce di scienza rischiara il mondo?”.
La sorte dell’Avanti! non fu migliore di quella della precedente esperienza giornalistica del C.; i suoi quattordici numeri furono tutti sequestrati, ma ebbero ugualmente una certa diffusione. Quando venne infine arrestato il redattore responsabile A. Mancini, la pubblicazione fu sospesa. I compagni di Cesena gli misero allora a disposizione le colonne del Catilina; accettò con qualche riluttanza, poco entusiasta del titolo e dell’orientamento dei giornale: “Io penso”, ebbe a dire, “che lungi dallo spaventare la pubblica opinione, noi dobbiamo per quanto è da noi cercare di conciliarcela”. Sull’Avanti! saltò il fossato dell’impegno elettorale.
Le incertezze del presente lo indussero ad assecondare la sua mai sopita vocazione letteraria: dette alle stampe (Almanacco popolare, Imola 1882) una sorta di romanzo utopistico, Un sogno, in cui immaginava una Imola trasformata in cittadella socialista. Con stupore dell’autore, esso venne ristampato più volte su settimanali socialisti e in opuscolo. Nella prefazione alla quinta edizione (Firenze 1900), ricostruì la situazione che glielo aveva ispirato: “Eravamo nel 1881. La vecchia Internazionale si era venuta via via trasformando e rimodernando, ma non si trasformava né si rimodernava la condotta del governo verso di noi… In tanto squallore di vita, resa ogni azione impossibile, che far potevamo se non sognare? E sognai anch’io questo modestissimo sogno”. L’interesse per questo genere paraletterario non si esaurì qui. Il C. firmò anche la prefazione a un’altra operetta di intonazione utopistica, Un comune socialista (Brescia 1884), di Giovanni Rossi (pseud.: Cardias).
L’esigenza di un nuovo partito, enunciata nella lettera Agli amici di Romagna del 1879, si materializzò al convegno segreto di Rimini con la costituzione del Partito socialista rivoluzionario di Romagna (agosto 1881), poi Partito socialista rivoluzionario italiano (Forlì, 29 luglio 1884). Accanto al C. si trovarono, tra gli altri, protagonisti vecchi e nuovi del socialismo italiano, da N. Baldini a L. Musini a G. Zirardini ad A. Leonesi. La maggioranza confluì sulle posizioni del leader romagnolo, avverso all’identificazione della nuova formazione politica in federazione anarchica; la stessa denominazione prescelta doveva a suo avviso alludere a un modello di aggregazione non selettivo, aperto a tutte le tendenze socialiste.
Il partito costiano, a struttura federativa, fu l’antesignano del Partito socialista italiano e, per qualche tempo, l’unica organizzazione socialista di consistenza reale. Il programma, giudicato il frutto più maturo dei pensiero del C. (Della Peruta), derivava dalla fusione di elementi marxisti e blanquisti. Esso rifletteva anche una delle più radicate convinzioni del suo fondatore, l’idea cioè che in una società come quella italiana, scarsamente industrializzata, anche l’ancoraggio sociale di un partito rivoluzionario dovesse essere più popolare che operaio. Nel delineare la strategia politica del nuovo partito fu molto attento all’esperienza d’Oltralpe. Lo Avanti! pubblicò nell’agosto 1882 il programma del Parti ouvrier français, e precedenti tentativi di integrazione della vita amministrativa effettuati da comitati operai parigini non dovettero essere estranei alla campagna per il suffragio universale amministrativo e per la riforma della legge comunale e provinciale inaugurata dal C. l’8 luglio con un comizio al politeama Golinelli di Imola. Essa era concepita come una mobilitazione unitaria e poté valersi dell’apporto radicale e repubblicano, ma fu intensa quanto breve e priva di risultati immediati. Nel corso di questa campagna, il Partito socialista rivoluzionario rilevò per primo, in Italia, le potenzialità democratiche delle amministrazioni locali, provvide quindi all’elaborazione di un programma di governo e coniò la formula “impadroniamoci dei comuni” su cui il Partito socialista italiano fonderà in seguito tante delle sue fortune. Come strumento del progetto più ambizioso del C., però, il nuovo partito si rivelò fallimentare. Mancò infatti il suo obiettivo aggregante, la sua fluidità ideologica si rivelò un requisito inadeguato a calamitare le forze socialiste già esistenti, inetto ad arginarne la vocazione centrifuga.
Dal momento della fondazione del Partito socialista rivoluzionario Ravenna divenne il quartier generale del C., e sarà anche il suo primo collegio elettorale. La riforma elettorale del 1882 confermò e definì una volta per tutte la sua nuova rotta politica. L’iniziale astensionismo dell’opposizione romagnola, egemonizzata dai repubblicani, indusse dapprima il C. a recedere sulle cosiddette candidature di protesta, candidature cioè puramente simboliche, svincolate dall’impegno parlamentare. Egli guardò poi di buon occhio il profilarsi, in Romagna, di un accordo tra repubblicani e socialisti: “Quivi – scrisse – è ancora possibile che la parte migliore della borghesia dia la mano al popolo e combatta con esso”. Il 27 ag. 1882 repubblicani, socialisti e democratici di tutta la regione si dettero convegno per redigere una piattaforma elettorale comune. Si costituì l’Unione democratica romagnola e il C. venne candidato.
Il messaggio socialista raggiunse così per la prima volta le campagne imolesi; il programma elettorale fu distribuito in migliaia di copie sotto forma di opuscolo dal titolo Per chi dovete votare;il manifesto con l’immagine del C. recava la dicitura: “Volete la tassa sul macinato? Votate per Codronchi [l’antagonista moderato]. Volete l’abolizione della tassa sul macinato? Votate per Costa”. Candidature socialiste erano state presentate per la prima volta in trentatré collegi, ma il C. fu l’unico eletto. Il suo nome venne inserito in oltre dieci liste e ottenne in tutto 15.000 voti, quelli determinanti però furono i 3.654 riportati a Ravenna; a Imola, sua città natale, il voto dei centri rurali del basso Bolognese premiò invece i moderati.
Ebbe così inizio una lunga carriera parlamentare, che avrebbe conosciuto solo una breve parentesi e si sarebbe protratta fino alla fine di una vita intensa quanto relativamente breve. Ma la svolta politica dell’79 aveva portato il C. su un terreno dove le sue risorse non erano più concorrenziali; la nuova generazione socialista avrebbe da allora in poi guardato a lui con rispetto ma anche con malcelato fastidio. Il giudizio riduttivo espresso alcuni anni più tardi da C. Lazzari sulla sua elezione a deputato ne fu una delle prime avvisaglie: “Costa”, scrisse Lazzari in un rapporto destinato al congresso americano di Buffalo, “doveva la sua riuscita più alla simpatia che ispirava il suo apostolato coraggioso che alla diffusione dei suoi principi” (cit. in Perli).
Al momento dell’opzione elettorale, i vecchi compagni lo avevano accusato di tradimento, e quando egli, all’ingresso in Parlamento, giurò la fedeltà al re prevista dallo statuto, la loro reazione assunse toni di inusitata virulenza. Gli si addebitò di godere di privilegi borghesi, mentre le ristrettezze finanziarie continuavano a perseguitarlo e la carica parlamentare non prevedeva ancora alcuna indennità. Inoltre, il caso, o le autorità costituite, vollero che i giornali su cui doveva comparire la giustificazione di questo gesto venissero tutti sequestrati e solo il 28 genn. 1883 Il Moto di Imola poté pubblicarne la dichiarazione: “Il giuramento, vi diceva, è un impegno morale a chi lo compie liberamente. Chi vi si sottomette per necessità non contrae nessun dovere, perché egli nulla promette. ” Una professione di nicodemismo politico che non poteva certo mettere a tacere i suoi detrattori. Quando il giornale Tito Vezio di Milano, diretto da C. Monticelli, poi passato nelle file socialiste, lo attaccò duramente, il C. si recò a Milano per sostenere un contraddittorio, presieduto dal venticinquenne F. Turati. La sua linea di condotta vi riscosse un largo consenso. Qualche mese prima, del resto, O. Gnocchi Viani lo aveva ragguagliato in questi termini sulla situazione milanese: “In mezzo ai repubblicani prevalgono idee di astensione o delle candidature non giuranti: tra gli operai invece è dominante il concetto dei deputati che alla Camera parlino in loro nome“(cit. in Schiavi).
La carica di deputato lo costringeva ora a frequenti viaggi a Roma, ed egli ne approfittò per stringere una serie di legami con gli ambienti operai della capitale. Si trovò in piena febbre edilizia, quando la grande immigrazione agricola, potenziale serbatoio sociale dell’anarchismo, dette la impressione che Roma potesse capeggiare la riscossa contro il socialismo legalitario. Il C. cercò di riprendere i contatti con gli ambienti internazionalisti, nell’intento di riorganizzarli e conquistarli alle sue posizioni. I suoi nuovi seguaci e i bakuninisti irriducibili riprodussero così anche a Roma il conflitto tra anarchismo e socialismo.
Il movimento romano era dominato dalla democrazia radicale, in mano agli artefici dello sviluppo edilizio della capitale; uno dei personaggi più popolari dello schieramento era Ricciotti Garibaldi, che godeva il riflesso del mito paterno, assai vivo tra il proletariato urbano, e aveva instaurato un solido controllo su di esso “attraverso la rete dei capi-popolo e dei capi operai che formavano l’ossatura della democrazia romana” (Cafagna). Il C. riuscì a ribaltare tali rapporti di forza e si assicurò per qualche anno una leadership incontrastata. Tale era il suo impegno e tanta l’importanza attribuita a questa situazione che, nel 1884, trasferì a Roma la redazione del risorto Avanti!. Quando sopraggiunse la crisi edilizia, promosse la fondazione della Federazione operaia socialista, dove vecchi internazionalisti erano affiancati da elementi più giovani, ma poi non riuscì più a controllare la marea montante dell’esasperazione operaia e il suo moderatismo dovette cedere alla nuova generazione anarchica.
Il C. perseguiva in questo periodo, difficile dire con quanta lucidità, e vi insisterà fino alla tardiva adesione al Partito socialista italiano, due linee strategiche alquanto divergenti: la ricerca incessante e quasi puntigliosa di contatti con l’internazionalismo di base, che egli intendeva, si è detto, guadagnare all’integrazione politica e, al tempo stesso, di ampie coalizioni democratiche di tipo verticistico e parlamentaristico. Fu così tra i promotori del Fascio democratico (8 ag. 1883), sorto dall’appuntamento congressuale di trecentoquindici associazioni radicali e socialiste, svoltosi alla presenza degli esponenti più in vista del momento, da F. Cavallotti a A. Saffi, a G. Bovio, ecc. Il Fascio si prefiggeva di “promuovere l’unione delle forze vive del popolo contro gli attuali ordinamenti politici e sociali, tanto nelle agitazioni pacifiche quanto nelle agitazioni rivoluzionarie” (cit. in Lupparini). Il C. entrò con Cavallotti e Bovio nel Comitato centrale della coalizione, ma questo gesto venne censurato da alcuni ambienti socialisti. Kerbs in particolare criticò con durezza una vocazione unitaria che rischiava di compromettere un’identità e un’autonomia socialista ancora precarie. Anche l’astio degli antichi compagni si rinvigorì; gli furono rinfacciate la morte prematura di Bakunin e la perdita della ragione patita da Cafiero, rinchiuso dal 1883 nel manicomio di San Bonifacio (Firenze). A Parigi, dove andò a presiedere un congresso internazionale, alcuni italiani lo apostrofarono di assassino e traditore. Questa campagna diffamatoria trovò echi anche nella stampa conservatrice.
Furono forse questi gli anni più amari. La malattia di A. Kuliscioff si aggravò ed ella dovette cercare sollievo nel clima mite di Napoli; il C. la raggiunse, ma questa sollecitudine non compensò la reciproca freddezza, che ormai aveva soppiantato gli antichi slanci. L’anno successivo, Anna si trasferì a Milano e si legò a F. Turati, allora molto vicino al Costa. L’attivismo indefesso non l’avevaabbandonato, ma tendeva ora a confondersi con un impulso di evasione da una realtà fatta di molte durezze. Dopo aver subito un nuovo processo per un vilipendio mai perpetrato e una condanna a un anno di reclusione, il C. partì per Napoli, dove era scoppiata un’epidemia di colera. Lì prese contatto con il Comitato della Croce verde, composto di volontari appartenenti alla massoneria e ai partiti estremi, diretto da G. Bovio, gran maestro della loggia napoletana. Si prodigò con grande abnegazione tra l’ammirazione generale e altrettanto fece, l’anno successivo, 1885, in circostanza analoga, a Palermo. Alla fine del soggiorno napoletano, venne accolto nella massoneria, dove avrebbe raggiunto il grado 32. Questa nuova appartenenza gli costò la rottura dei rapporti personali con E. Malatesta, che era uscito dalla massoneria nel 1876.
Non si può dire che il C., nella sua prima esperienza parlamentare, avesse troppo brillato. Presentò due interrogazioni per la libertà di riunione e contro la ammonizione (seduta del 21 giugno 1884); illustrò un o. d. g. sulle convenzioni ferroviarie e a favore della statalizzazione dell’esercizio ferroviario, e manifestò il suo dissenso dall’impresa africana.
Nel 1886 venne eletto di nuovo a Ravenna con 5.234 suffragi, e di nuovo Imola gli negò il necessario quoziente di voti. La campagna elettorale mise in luce la sua sempre crescente popolarità; quando si presentava per tenere un comizio, e ne fece innumerevoli, veniva spesso accolto dalla banda musicale al suono dell’inno di Garibaldi.
La decisione del partito operaio di cimentarsi con queste elezioni provocò una isterica reazione dei radicali; timorosi di perdere l’elettorato operaio, imbastirono una campagna calunniosa contro il partito operaio accusato di essere foraggiato dal governo. Quando, nel clima di tensione generato dalle lotte contadine del Mantovano, il partito venne sciolto e molti suoi capi arrestati (2 giugno), la solidarietà espressa dal C. in Parlamento fu il logico corollario di un imparentamento politico che risaliva al secondo congresso operaista (Mantova, 25 apr. 1886). Ormai persuaso della intenzione radicale di fagocitare il movimento socialista, egli aveva abbandonato il Fascio della democrazia e si era avvicinato al Partito operaio portando con sé molti circoli anarchici.
Il ventilato progetto fusionista aveva richiamato a Mantova una folta rappresentanza di socialisti romagnoli, ma né gli esponenti del Partito operaio italiano e neppure forse lo stesso C. erano troppo convinti di una soluzione del genere. Il C. propendeva piuttosto per una sorta di divisione del lavoro tra le due formazioni e alla tribuna congressuale teorizzò la complementarietà tra lotta politica e lotta economica, espressioni della stessa classe sociale. Il congresso si concluse con un patto di azione comune e la Commissione federale venne dislocata a Parma, dove il costiano Musini contava qualche legame con l’ambiente bracciantile.
Rispetto alla nuova formazione politica, il C. si attribuì anche un ruolo di mediatore; difese l’enfasi economicista del partito operaio dalle sollecitazioni anarchiche per una piattaforma programmatica meno riduttiva, e al congresso successivo (Pavia, 18-19 sett. 1887) cercò senza successo di allargare l’appartenenza operaista dai lavoratori manuali a “tutti quei cittadini che credono di accettarne il programma”.
Nel 1886 A. Lanzone fondava a Lugo la Rivista italiana del socialismo, una sorta di riedizione della prima rivista del C., che fece pervenire al direttore una lettera augurale in cui ricordava il suo precedente tentativo e assicurava la sua collaborazione. Ma anche di questa videro la luce pochi numeri, per le solite difficoltà finanziarie. Il Lanzone fu costretto ad emigrare.
L’Italia stava allora attraversando uno dei suoi momenti più critici; si era in piena recessione economica e la classe politica governativa manovrava per dirottare verso prospettive colonialiste l’inquietudine e il malessere sociale. Ma le imprese africane si stavano traducendo in ulteriori frustrazioni collettive, e il C. riuscì a fornire al disorientamento generale una efficace chiave di lettura e di mobilitazione politica. Il 1º febbr. 1887 Depretis lesse alla Camera il telegramma con cui il gen. Gené notificava la sconfitta di Dogali, e presentò un o. d. g. volto ad ottenere l’autorizzazione ad una spesa straordinaria di cinque milioni. Due giorni dopo, lo storico intervento del C.: egli criticò con durezza l’imperialismo governativo, accusandolo di incostituzionalità, di finalità oscure, di estraneità a qualsiasi esigenza reale del paese, e chiese il ritiro delle truppe dall’Africa. Il discorso poté essere portato a termine solo tra molte interruzioni, e il C. così concluse: “Or bene, noi, francamente, per un’impresa non nobile, non ci sentiamo di dare né un uomo né un soldo. Richiamate le milizie dall’Africa e vi apriremo tutti i crediti che chiederete, ma per continuare nelle pazzie africane, noi non vi daremo, ripeto, né un uomo né un soldo”.
Il discorso del C. fu uno dei prototipi di un anticolonialismo socialista ancora in nuce in tutta l’Europa, su cui ben poco era stato scritto o detto, e fu quindi una dimostrazione, oltreché di coraggio, di tempestività e di inventiva politica. Nel corso di un’importante conferenza tenutasi a Siena il 18 aprile di quell’anno, ebbe modo di approfondire e precisare il suo pensiero. Egli dichiarò un’ostilità non pregiudiziale verso la politica coloniale; condivideva anzi l’enfasi positivista sulla missione della “civiltà” verso la “barbarie”: o la civiltà, disse, ha il diritto di diffondersi, e però di abbattere gli ostacoli che le si possono opporre sul suo cammino”. Ma riteneva che i mezzi più adatti non fossero né le conquiste né le violenze né la distruzione sistematica, ma un’azione come “da buoni padri … verso i figli”, l’aiuto “a percorrere la spinosa carriera della civiltà”, il sostegno “negli sforzi che [i popoli “barbari”] far possono per progredire”. Il suo anticolonialismo era dunque sostanziato di pacifismo, e l’espansionismo italiano era per lui delegittimato dalla presenza dell’Africa in Italia, dalla possibilità della colonizzazione interna, dal fatto insomma che il vero problema da risolvere fosse la miseria delle masse operaie e contadine della penisola.
Come è stato di recente osservato, questa argomentazione non era esente né da ambiguità, né perciò stesso da fragilità (Rampazzi), ma la posizione del C. funse ugualmente da pietra miliare nel faticoso e contraddittorio dispiegarsi del successivo anticolonialismo socialista. Inoltre, l’efficacia simbolica delle sue formule riassuntive (“né un uomo né un soldo” e “via dall’Africa”) le abilitò ad una penetrazione di massa certamente molto superiore a quella di argomentazioni teorico-politiche, tanto da farle diventare un veicolo di socializzazione politica collettiva.
La popolarità della presa di posizione del C. fu enorme. L’intervento fu pubblicato sulla Rivista italiana del socialismo e largamente riprodotto sui giornali popolari; Marabini ricorda di averne diffuso tra i contadini il testo stampato sul settimanale imolese Il Moto. Esso introdusse poi un motivo di chiarificazione, e di divisione, tra le forze democratiche: il Fascio operaio appoggiò la tesi del C. e aprì una sottoscrizione per l’agitazione “Il ritiro delle truppe dall’Africa”, mentre il radicale Consolato operaio si dissociò da questa posizione.
La crisi politico-sociale in cui versava il paese non cessava intanto di approfondirsi. Durante uno dei suoi soggiorni a Roma, il C. prese parte a una dimostrazione di edili disoccupati seguita ad una commemorazione di G. Oberdan. Gli scontri con la polizia furono molto duri. Il C., che si trovava alla testa del corteo, cercò di difendersi agitando un ombrello, e ne ebbe una condanna a tre anni, ma il Parlamento rifiutò l’autorizzazione a procedere.
Recatosi quindi in Francia, rappresentò l’Italia, con F. S. Merlino e A. Cipriani, al congresso possibilista di Parigi di rue Lancry (1889), contemporaneo a quello rivale, marxista, della sala Petrelle. Turati gli aveva affidato l’incarico di adoperarsi per la conciliazione tra le due tendenze, ma i preventivi negoziati internazionali erano già irrimediabilmente falliti. Sui lavori del congresso, il C. inviò una serie di corrispondenze a Il Messaggero, che già nel 1886 aveva pubblicato i suoi resoconti del processo di Venezia contro i contadini mantovani e che altre volte aveva ospitato i suoi scritti.
L’allargamento del suffragio amministrativo segnò la fine dell’egemonia del partito conservatore a Imola; nell’ottobre 1889 la coalizione democratica vinse le elezioni e il C. divenne per la prima volta consigliere comunale e provinciale. Dopo il suo rientro in Italia, la Camera autorizzò questa volta, il 21 marzo 1890, con centocinquantanove voti contro centonove, il procedimento giudiziario nei suoi confronti. In Parlamento, il sottosegretario di Stato A. Fortis gli offrì di soppiatto, in evidente segno di simpatia, del denaro per passare il confine; il C. non accettò, ma gli amici provvidero a fargli raggiungere Nizza.
Alle elezioni politiche parziali del 1890 venne rieletto a Ravenna con 7.041 voti e, per la prima volta, nel maggio, a Imola, con 4.398. La Camera annullò questa ultima elezione, per via del precedente risultato ravennate e perché l’esilio gli toglieva il diritto all’opzione. Nello stesso anno si tennero anche le elezioni politiche generali; fu di nuovo eletto a Ravenna e a Imola e, prima di rimpatriare, venne amnistiato. Il 5 dic. 1890 Imola gli tributava un’accoglienza trionfale.
Gli eventi cruciali della gestazione e della nascita del Partito socialista italiano videro il C. nell’insolita condizione di spettatore. Malgrado le calorose esortazioni di F. Turati, rifiutò di collaborare a Critica sociale, poco entusiasta di una rivista che doveva fungere da tramite con gli ambienti accademici e intellettuali e che propugnava quindi un socialismo molto lontano da queste preoccupazioni e sempre un po’ provinciale come il suo. Tuttavia sperò fino all’ultimo di far prevalere il suo schema di partito pluralista privo di discriminanti antianarchiche, e quando il congresso di Genova (14-15 ag. 1892) dette vita al Partito dei lavoratori italiani ma anche alla secessione dagli anarchici, egli deluso e amareggiato, non partecipò né all’una né all’altra assemblea. Il commento del Turati fu quasi sprezzante: “Nell’insieme, disse di lui, ha fatto una pessima figura”. Al Partito socialista dei lavoratori italiani aderì soltanto l’anno successivo, al secondo congresso di Reggio Emilia (8-10 sett. 1893), e anche allora si vide respingere una proposta che era stata tanta parte della sua fase post-anarchica, la ricerca delle alleanze con i partiti democratici. Ciò ne accentuò il progressivo isolamento. Da allora si allontanò dalla vita di partito e si dedicò alla attività parlamentare. La nuova generazione socialista lo mummificò anzitempo confinandolo a ruoli puramente simbolici, quali la presidenza di quasi tutti i congressi.
Il clima autoritario dell’età crispina si tradusse anche in un tentativo di maggior controllo dell’elettorato; le elezioni politiche del novembre 1892 furono precedute da rimaneggiamenti dei meccanismi di espressione della volontà popolare. I collegi elettorali vennero modificati prescindendo dalle ripartizioni amministrative circondariali e mandamentali; lo scrutinio di lista, legato a una larga circoscrizione e a una dotazione di tre-cinque seggi, fu sostituito dal collegio uninominale, di dimensioni molto più ridotte. Al collegio di Imola venne sottratto il mandamento di Medicina, noto epicentro di lotte bracciantili e base elettorale socialista, e in sua vece venne incorporato il comune di Ozzano, indifferente alla candidatura del C., che risultò quindi perdente.
La delusione dovette essere forte. Mentre in Sicilia divampava il movimento dei Fasci, il C. rifiutò la proposta del Turati di partecipare all’inchiesta sui fatti di Caltavaturo (Palermo) a seguito di un’invasione di terre conclusa da scontri con i carabinieri. Si ritirò quindi nella natia Imola, dove alla carica di presidente della Congregazione di carità (11 maggio 1891), poté aggiungere anche quella di sindaco (17 nov. 1893). Ma non poté espletare neppure queste funzioni senza incorrere in difficoltà; alla Congregazione, la battaglia contro la gestione autoritaria del manicomio gli costò un duello, tre mesi di detenzione e un processo amministrativo; in municipio, si dedicò soprattutto al potenziamento dell’istruzione elementare. Ma questo pesante bilancio lo scoraggiò; si persuase di non essere tagliato per la vita amministrativa e preferì abbandonarla.
Intanto il Crispi, ricostituito subito il suo quarto ministero dopo le dimissioni del 5 giugno 1894, faceva rapidamente approvare alcune leggi – tra cui quella sui reati di stampa -, formalmente antianarchiche ma di facile estensione antisocialista. Iniziava una politica persecutoria antisocialista, culminata nel simultaneo scioglimento, ad opera dei prefetti, delle associazioni socialiste (22 ott. 1894). Il C., che riusciva però a sottrarsi all’arresto riparando a Lugano, ricevette così dal tribunale di Bologna una condanna a sei mesi per istigazione all’odio di classe. Poco dopo, malgrado le intimidazioni subite dall’elettorato, vinceva (1895) le elezioni parziali per la XVIII legislatura nel collegio di Budrio, dove era morto il deputato in carica, ma non ebbe modo di esercitare il mandato.
Il ritorno in Parlamento, nella XIX legislatura, lo rese di nuovo protagonista dell’opposizione antiafricana. Dopo le sconfitte di Amba Alagi e Abba Garima (1º genn. 1896), e dopo le dimissioni di Crispi (5 marzo), il C. presentò una mozione per porre in stato d’accusa il ministero; pochi giorni dopo intervenne di nuovo a chiedere la completa amnistia per i fatti di Sicilia e l’abrogazione delle sentenze dei tribunali militari e delle condanne al domicilio coatto.
L’attività parlamentare non aveva fatto dimenticare al C. né la sua regione né le classi contadine. Verso queste ultime aveva sempre mostrato una disponibilità e una sensibilità spiccate, e l’altezzosità di molti socialisti settentrionali verso i contadini del Sud non era stata secondaria nel sedimentare la sua dose di diffidenza verso il nuovo partito. Il C. aveva seguito molto da vicino il sorgere e le esperienze del socialismo agrario emiliano, era legato da una profonda stima reciproca all’ormai leggendario G. Massarenti, fu più volte al fianco dei braccianti di Molinella nel corso dei grandiosi scioperi del ’97-’98 e li difese in Parlamento.
Durante i moti di Milano, venne arrestato, nel maggio, all’arrivo alla stazione e l’11 fu rinchiuso nel carcere giudiziario dove trascorse cinquantasette giorni. Dal 26 del mese, utilizzando i fogli protocollo passati dalla direzione del carcere, cominciò a scrivere, sotto forma di appunti, una sorta di autobiografia, occasione di ripensamento e sistemazione del suo passato politico. Poco più tardi fu in prima linea, durante l’ostruzionismo del giugno 1899 contro le leggi Pelloux e membro, col repubblicano E. Pantano e il radicale G. L. Basetti, del comitato unitario di coordinamento dei partiti dell’estrema Sinistra. Un decreto reale del 30 giugno chiuse la sessione parlamentare facendo decadere la immunità; sul C. pendeva la condanna a sei mesi, ridotta a tre, cui si era sottratto nel 1895. Venne quindi arrestato il giorno dopo all’uscita da Montecitorio e tradotto nel carcere di Bologna, dove scontò la pena.
Col nuovo secolo e con la svolta giolittiana la sua immagine pubblica si venne sempre più appannando; il C. divenne quasi un sopravvissuto. Nel Partito socialista, col profilarsi delle prime divisioni interne, si schierò con la corrente riformista (Imola, settembre 1902), ma quando le segmentazioni socialiste si moltiplicarono (Bologna, 1904). preferì il silenzio e non nascose, in sedi meno ufficiali, la sua profonda delusione: “No”, disse nel corso di un’intervista, “a Imola non ci fu ipocrisia. A Imola ci gettammo cordialmente, sinceramente, tutti nelle braccia gli uni degli altri; a Imola, una nota alta di sentimento, di entusiasmo … comune ci univa ancora tutti”.
Gli ultimi anni furono amareggiati dai pettegolezzi sulla sua vita privata. La stampa non gli risparmiò i toni sarcastici quando la figlia Andreina sposò con rito religioso un giovane esponente dell’alta borghesia milanese. Al matrimonio finì col convertirsi anche lui, e ai primi del 1906 sposò a Nizza con rito civile la faentina Angelina Cicognani, una ricca vedova proprietaria di una sartoria; ma non fu un’unione felice. Questa ansia di stabilità dissimulava una perdurante inquietudine, che ebbe una ultima impennata quando venne eletto vicepresidente della Camera (25 marzo 1909) e, suscitando violente polemiche, si rifiutò di portare al Quirinale la risposta al discorso della Corona.
Morì a Imola il 19 genn. 1910.
Tratto da – Dizionario Biografico degli Italiani Treccani – Volume 30 (1984) – di Andreina De Clementi